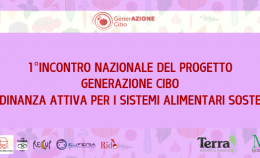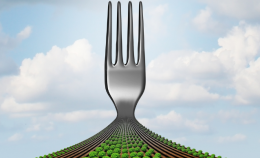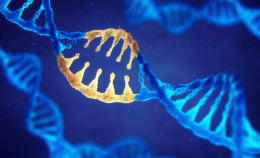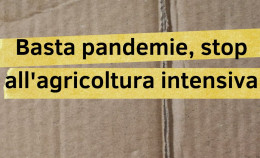Cronache dalla COP 25
Pubblicato da Redazione
il 07/12/2019
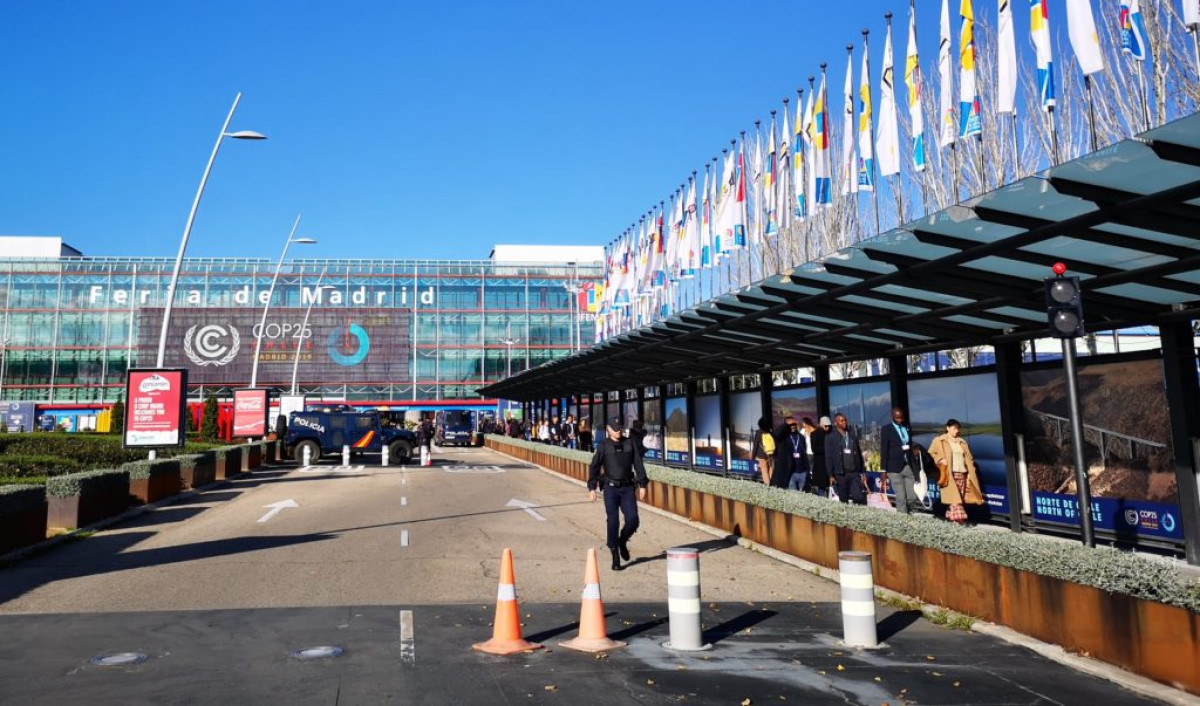
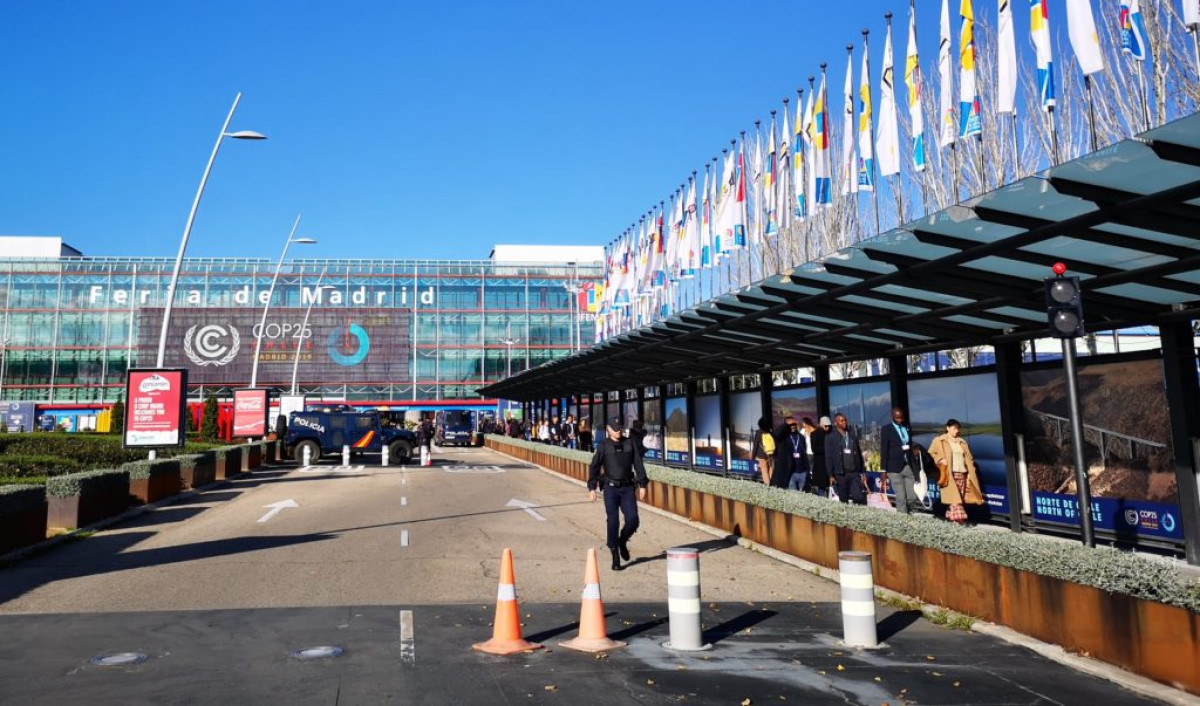
16 dicembre - La COP fallisce mentre il pianeta va a fuoco
Con 44 ore di ritardo sulla tabella di marcia si è chiusa la Conferenza ONU sul clima più lunga di sempre, ma il risultato finale è l'ennesimo fallimento. Quello che ci portiamo a casa da Madrid è un misto di stupore e rassegnazione: raramente ci è capitato di vedere un tale distacco fra le istanze promosse da giovani, popoli indigeni, organizzazioni ambientaliste e della società civile e le schermaglie diplomatiche di piccolo cabotaggio che parallelamente si consumavano nelle sale della COP 25. Nonostante i governi tentino a parole di accarezzare il crescente movimento per il clima e i giovani che lo animano, nei fatti al momento di dare risposte diventano impermeabili e sordi. La scelta di assecondare ancora una volta interessi corporativi ormai agonizzanti ha deluso tutti, specie perché questo significa perdere un altro dei 10 anni e poco più che abbiamo di fronte prima che si raggiunga un punto di non ritorno nella crisi climatica. Nonostante la richiesta agli esperti di fornire scenari per evitare un riscaldamento globale superiore al grado e mezzo, nonostante l'inclusione di questi target nell'ultimo accordo sul clima (Parigi, 2015), oggi gli impegni nazionali se messi insieme portano alla crescita delle temperature di oltre 3 °C alla fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali. In pochi hanno promesso di aggiornarli entro il 2020 in maniera da raggiungere le zero emissioni nette al 2050, nonostante il documento finale approvato intorno alle 14 di ieri sia pieno di enfasi sull'aumento dell'ambizione.
La verità è che il risultato di questa COP è l'ennesima campana a morto su un sistema di dialogo multilaterale che tenta senza successo di comporre interessi troppo divergenti. In venticinque anni di negoziati il metodo di lavoro è cambiato, ma i risultati restano disastrosi. Si è passati dall'approvazione di un accordo vincolante, ratificato solo da pochi paesi e con anni di ritardo (Kyoto), a un approccio meno vincolante che ha prodotto l'accordo di Parigi, ratificato da tutti ma non rispettato da nessuno. In questo quadro, la COP 25 è l'ennesimo passo falso nel tentativo di spingere la comunità internazionale a mantenere le sue promesse di aumentare progressivamente l'impegno a ridurre le emissioni climalteranti in linea con obiettivi concordati sulla base di studi dell'IPCC. La transizione è considerata necessaria per evitare un aumento di temperatura media globale che porterebbe a sconvolgimenti socioecologici tali da mettere a repentaglio la vita di milioni di persone, le cui terre diverrebbero inabitabili.
Al di là del pozzo di tecnicismi in cui è stata spinta la discussione nell'ambito delle COP, la realtà è che i problemi di fondo che portano al fallimento sistematico delle trattative sono eminentemente politici e legati a un modo di organizzare le società nella natura estrattivo e competitivo: il passaggio di fase cui andiamo incontro richiederebbe invece solidarietà e cooperazione a scala globale, con trasferimenti economici e di conoscenze dai paesi ricchi a quelli poveri, che hanno poche responsabilità per la crisi climatica e però subiranno la maggior parte degli impatti. Solo una visione del mondo egualitaria può sostenere lo sforzo epocale per costruire un rapporto armonico fra le società, gli individui e tutte le forme del vivente, evitando un eccessivo riscaldamento globale e gli effetti più disastrosi del cambiamento climatico. Ma non è questo lo spirito del tempo.
È così che il faticoso multilateralismo promosso dalle Nazioni Unite genera costantemente minuscoli risultati. I paesi industrializzati - è successo anche stavolta - non vogliono cedere alle richieste di fondi avanzate da quelli in via di sviluppo, tra i quali si mimetizzano per convenienza anche colossi del calibro di Brasile, Cina e India. Queste economie possenti che competono ormai con i giganti occidentali, non vogliono vincoli all'inquinamento per non perdere l'abbrivio nella crescita. I paesi più agiati, che performano solo un pochino meglio (i cali, le stasi o i bassi aumenti delle emissioni sono dovuti più alla crisi economica e alle delocalizzazioni che non a vere politiche di mitigazione), non vogliono aumentare la competitività degli altri pagando loro misure di adattamento e mitigazione. In questo tiro alla fune si lacera il futuro dei paesi più poveri, che sono anche quelli più vulnerabili alle intemperie causate dal cambiamento climatico. Avrebbero bisogno di forti aiuti economici, trasferimenti di competenze e tecnologie, ma in questa COP al momento topico sono stati esclusi dagli incontri fra le delegazioni. Un gesto arrogante che rievoca le green room dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), dove i grandi della terra si chiudevano per decidere le basi degli accordi da imporre poi - con le buone o con le cattive - ai governi del Sud globale.
Le insanabili divergenze fra blocchi geopolitici sono la ragione per cui, inevitabilmente, la diplomazia prova infine a buttarla sulla finanza, protraendo la brutta abitudine a tentare di risolvere con il mercato problemi creati dal mercato. I sistemi di scambio delle emissioni previsti dall'Articolo 6 dell'accordo di Parigi - e prima dal Clean Development Mechanism del Protocollo di Kyoto - sono la scappatoia per tutti, il modo per dimostrare sulla carta di aver raggiunto traguardi che nella realtà restano lontani. Dovrebbero servire a ridurre le emissioni, ma in realtà alimentano soltanto una compravendita di crediti di carbonio fra paesi e fra aziende, che rallenta l'azione climatica concreta. Poi a un certo punto qualcuno fa dei conti e nota la discrepanza, scoppia lo scandalo (Kyoto docet) e ci si siede per discutere regole più stringenti. È quello che si è provato a fare qui a Madrid, per evitare la nascita di un mercato del carbonio drogato da vecchi crediti-spazzatura detenuti da alcuni paesi (soprattutto l'Australia) o il doppio conteggio delle riduzioni di CO2. Ma la trattativa è fallita (tutto rinviato alla COP 26 di Glasgow l'anno prossimo), perché il modello di sviluppo che produce queste scappatoie sta in piedi solo se trucca le carte. Dovremmo finalmente renderci conto che un sistema basato su competizione, diseguaglianze e mercificazione non può evitare la crisi ecologica.
Intanto, è sempre più forte la pressione internazionale della società civile per evitare un cataclisma. Il problema è che questo auspicabile rivolgimento storico potrebbe verificarsi troppo tardi. Le forze che remano contro sono potenti, ma la sfida che abbiamo davanti è irripetibile: dobbiamo trovare insieme la forza per cambiare la conversazione mondiale sulla giustizia, l'ecologia e la solidarietà, o sarà impossibile costruire un futuro diverso da quello che si profila oggi all'orizzonte.
12 dicembre
L’immagine che più ci è rimasta impressa per raccontare la giornata di ieri è quella di un poliziotto che, davanti alla stanza in cui si svolgono i negoziati, tenta con le buone di placare la protesta di duecento fra attivisti e rappresentanti delle popolazioni indigene impegnati in cori e slogan contro i governi all’interno. La storia non finisce bene: i manifestanti sono stati privati dei badge e cacciati dalla Feria de Madrid, dove si svolge la COP 25. Non potranno più rientrare, nemmeno nei prossimi giorni, ma il gesto - hanno detto - era giustificato: “Non abbiamo avuto altra scelta che violare le regole della diplomazia internazionale e disturbare i negoziati”, ha spiegato Daira Tukano dell’omonima popolazione che vive nel nordest del Brasile. Anche fuori dal complesso, i dimostranti hanno continuato a cantare una canzone che recita: “Chiediamo al Nord del mondo / di ascoltare le nostre voci / No a false soluzioni / e no al mercato delle emissioni!”
Richieste simili, con toni differenti, sono state avanzate in mattinata da giovani e organizzazioni ambientaliste sul palco della gigantesca Room Baker, teatro dei negoziati fra i paesi della Convenzione ONU sul cambiamento climatico (UNFCCC). Nella sessione dedicata a governi e ONG concordi nell’aumentare il livello degli impegni globali per la riduzione delle emissioni, sono intervenute fra gli altri Greta Thunberg - fresca di copertina del Time - e Jennifer Morgan, direttrice di Greenpeace International. “Non avevo mai visto un tale divario tra ciò che accade all'interno di queste mura e all'esterno, è un divario enorme”, ha detto la storica ambientalista, chiedendo ai leader globali di “smettere di sentire le imprese e di ascoltare invece i bambini di tutto il mondo”.
“Ogni grande cambiamento storico è venuto dal popolo”, ha dichiarato invece Greta, in un discorso di 11 minuti in cui ha fornito molti numeri e dati. “Fra tre settimane entreremo in un nuovo decennio, un decennio che definirà il nostro futuro. In questo momento siamo alla disperata ricerca di qualche segno di speranza, e io dico che la speranza c’è. L'ho vista, ma non proviene da governi o imprese, proviene dal popolo”. La passerella dei governi e l’approvazione del decreto clima in Italia
Questi momenti di attivismo e di protesta hanno allargato la frattura fra governi e società civile sui temi del clima. Una frattura resa ancor più evidente dalla passerella stucchevole che li ha inframmezzati: ministri di decine di Paesi hanno salito le scalette che portano al palco per magnificare gli sforzi dei loro governi e concludere con appelli alla buona volontà di tutti. Fra questi, oggi è intervenuto anche Sergio Costa, Ministro italiano dell’Ambiente, che ha rivendicato il Decreto clima approvato ieri alla Camera in via definitiva. Lo ha definito “uno dei primi al mondo”, che testimonierebbe l’impegno del governo sul tema facendo il paio con la proposta del Ministro dell’Istruzione - Lorenzo Fioramonti - di introdurre lo studio dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile nelle scuole.
Tuttavia, fra le pieghe del Decreto clima si fatica a trovare misure che aiuteranno realmente il Paese nella transizione ecologica. Quella più significativa - il taglio ai sussidi ambientalmente dannosi (SAD) - è stata rimossa e rinviata alla legge di bilancio. La prima versione del provvedimento, invece, prevedeva l’eliminazione totale di questi aiuti (pari a circa 19 miliardi nel 2017) entro il 2040, partendo dal 2020 con tagli di almeno il 10% l’anno. Fra le note positive del testo c’è l’istituzione del portale che dovrebbe facilitare l’accesso dei cittadini ai dati ambientali, 255 milioni di incentivi sulla mobilità sostenibile e finanziamenti per la riforestazione urbana e l’economia circolare. Infine, contributi a fondo perduto (per un massimo di 5 mila euro) agli esercizi commerciali che venderanno prodotti sfusi o alla spina. Tutte misure di piccolo cabotaggio, mentre non si vede l’ombra di un cambio di modello energetico e produttivo.
Del resto, il “cambio di paradigma” invocato da tanti relatori sul palco della COP non trova riscontro in nessun passaggio dei documenti negoziali consegnati dai tecnici alla politica all’inizio di questa settimana. Brasile, Australia e Arabia Saudita ancora bloccano i tentativi di raggiungere un accordo sulle regole alla base dei mercati del carbonio, la Cina è riuscita a far rimandare al 2020 l’approvazione di un sistema trasparente per il conteggio delle emissioni e gli Stati Uniti rifiutano di essere considerati fra i responsabili della crisi climatica, fatto che li costringerebbe a versare aiuti finanziari ai paesi più impattati.
Inoltre, ancora una volta, come già successo a Katowice durante la COP 24, c’è forte disaccordo sulla terminologia da utilizzare per recepire le ultime evidenze scientifiche e in particolare i due Rapporti Speciali pubblicati quest’anno dall’IPCC sulle conseguenze dei cambiamenti climatici sui Territori e sull’Oceano e la Criosfera, che nella bozza di Conclusioni proposta vengono semplicemente “noted”, registrati.
Il Green (Brown) Deal dell’Unione Europea
Con l’avanzamento a rilento dei negoziati, aumenta la pressione sull’Unione Europea da parte della società civile ma anche del settore economico e finanziario - con toni più accomodanti - per prendere in mano il dibattito e lanciare un forte segnale di leadership. E proprio oggi la presidente della Commissione Europea ha presentato al Parlamento la proposta del Green Deal, che domani andrà all’esame del Consiglio Europeo per l’approvazione definitiva. “Dobbiamo essere ambiziosi per quanto possibile, ma anche realistici quando necessario”, ha detto Ursula Von Der Leyen introducendo le misure del nuovo piano per il clima a un’Eurocamera che appena due settimane fa aveva dichiarato l’emergenza climatica.
Eppure, ancora una volta, la prudenza e il realismo, o piuttosto la realpolitik, sembrano avere avuto la meglio rispetto alle richieste pressanti della società civile di politiche coraggiose per contrastare i cambiamenti climatici. La punta di diamante del nuovo Piano è infatti il raggiungimento della neutralità delle emissioni di gas serra nel 2050: tante ne manderemo in atmosfera, tante ne dovremo rimuovere attraverso mari, foreste, terreni e tecnologie che, nelle parole di Greta, “non esistono e forse non esisteranno mai”.
Se è vero che nel Rapporto Speciale pubblicato dall’IPCC (il Gruppo Intergovernativo delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) a ottobre 2018 - al quale il Piano europeo dovrebbe rispondere - si chiede che le emissioni globali raggiungano la neutralità nel 2050, è anche vero che l’Europa dovrebbe tener conto delle proprie responsabilità storiche nel determinare la crisi climatica. Inoltre, date le maggiori capacità economiche e tecnologiche, l’obiettivo a cui dovrebbe mirare è notevolmente più ambizioso. Climate Action Network Europe, in un comunicato dello scorso settembre, chiedeva che la neutralità delle emissioni fosse raggiunta già nel 2040, e che già nel 2030 vi fosse un taglio del 65% rispetto al 1990. Il tutto basato su solide prove scientifiche.
Invece, l’Unione Europea continua a rimandare la decisione sull’obiettivo da adottare nel 2030, rinviando ancora una volta l’addio alle fonti fossili. Von Der Leyen ha annunciato oggi infatti che bisognerà aspettare fino alla prossima estate prima che la Commissione predisponga uno studio di prospettiva sui due possibili nuovi target di riduzione delle emissioni al 2030, ovvero del -50% o -55% rispetto al 1990. Questo ritarderebbe ulteriormente la decisione finale del Consiglio sul percorso da adottare, che in qualsiasi caso ancora una volta sarebbe troppo poco ambizioso rispetto alle evidenze scientifiche.
Come ha detto Marie Toussaint, parlamentare dei Verdi/EFA nonché fondatrice di Notre Affaire à Tous - ONG francese che ha promosso la campagna L’affaire du siècle e il ricorso per vie legali contro le politiche climatiche francesi considerate non abbastanza ambiziose -, questo Piano sarebbe stato fantastico dieci anni fa, ma adesso non è abbastanza. C’è bisogno di misure più stringenti e di controllo sull’operato degli Stati Membri affinché rispettino i propri impegni, e di un patto che sia allo stesso tempo ambientale e sociale.
Nei giorni in cui nei corridoi della Feria de Madrid i negoziati languono, in cui chi alza la voce per difendere i propri diritti viene allontanato dai luoghi di decisione, in cui l’OPEC continua a fare leva sulla povertà energetica per promuovere il petrolio “come parte della soluzione al cambiamento climatico”, mentre le voci delle organizzazioni osservatrici e portatrici delle istanze ambientaliste, femministe, dei popoli indigeni, degli agricoltori e dei lavoratori cadono nel vuoto di una sala deserta, anche l’Unione Europea rispedisce al mittente la richiesta di giustizia climatica e sociale, voltando le spalle a giovani e meno giovani che continuano a occupare strade e piazze. Ma la protesta non si fermerà qui. Di Cecilia Erba (A Sud Onlus) e Francesco Panié (Terra!)
10 dicembre
Che alla COP 25 sia arrivato il momento della politica, si vede subito. Le persone che ne solcano le ampie hall della Feria de Madrid sono più del doppio di quelle che ciondolavano pigramente fra i padiglioni la scorsa settimana, mentre file interminabili di umani provenienti da ogni zona del mondo serpeggiano fra i tavoli dei self service di pessima qualità. L'atmosfera sembra essersi fatta più carica di attesa, anche perché la discussione non sarà affatto semplice. Già ieri l'agenda della COP 25 aveva visto saltare o posticipare quasi tutti gli incontri a causa di uno stallo dei negoziati fra i gruppi tecnici. Così, le nuove bozze dei testi da passare alla politica per le decisioni finali sono state approvate solo a tarda sera. Molti paesi avevano chiesto tempo per leggere la versione aggiornata dell'Articolo 6, che istituisce un nuovo mercato del carbonio rimpiazzando quello già fallimentare creato nell'ambito del Protocollo di Kyoto (per i dettagli vedi qui sotto l'aggiornamento del 9 dicembre). Il testo è un compromesso al ribasso: nonostante i gran complimenti che i negoziatori si sono rivolti l'un l'altro per la collaborazione e la professionalità, non può passare inosservato il fatto che nel documento sia scomparso ogni riferimento al rispetto dei diritti umani e delle comunità native. Rimangono inoltre decine di frasi fra parentesi quadre, segno utilizzato per marcare le formulazioni sulle quali non c'è un consenso di tutti. Il presidente del gruppo di esperti che supporta le Nazioni Unite su faccende di carattere scientifico-tecnologico legate al clima (SBSTA) ha però dichiarato che, sebbene molte questioni restino irrisolte, all'orizzonte si vedono più chiaramente le opzioni fra cui la politica dovrà operare una scelta. La sessione si è conclusa con un abbraccio collettivo sul palco della gigantesca Baker Room.
Sugli altri punti chiave di questa COP regna lo stesso imbarazzo: quando alle 2:30 di stamattina il martelletto della presidenza ha chiuso i lavori dell'altro organismo tecnico (SBI) - che supporta l'implementazione dell'accordo di Parigi - i cinesi sapevano di aver vinto su tutta la linea. Infatti hanno chiesto la parola per ben sette volte solo per rivendicare il proprio successo negoziale: ritardare l'approvazione di alcune regole fondamentali come quelle che dovrebbero garantire una comunicazione trasparente delle emissioni nazionali. Il dragone ha stravinto questa prova di forza per due ragioni: l'assenza di una forte pressione contraria degli Stati Uniti, indeboliti dalla decisione di Trump di lasciare l'Accordo di Parigi, e il supporto del gruppo di 134 paesi in via di sviluppo che prende il nome di G77. Molti dei membri sono nazioni africane, gente per cui le parole "Nuova via della seta" significano più di qualcosa da qualche anno a questa parte.
Un'altra storica ferita delle COP è rimasta aperta: il negoziato tecnico non ha portato infatti a definire come aiutare i paesi vulnerabili a riprendersi da perdite e danni legati al cambiamento climatico. Il pendolo resta bloccato fra le due posizioni storiche: quella dei paesi industrializzati - che propongono ai più vulnerabili di aiutarli a sviluppare le competenze per far fronte ai cambiamenti climatici - e quella dei paesi poveri che chiedono invece fondi dedicati, una sorta di "risarcimento" per essere stati spinti sull'orlo del collasso dal turbo-sviluppo guidato dai più ricchi.
Viste le premesse, nei prossimi giorni il lavoro dei ministeri e dei loro team sarà quantomeno arduo. Le prime schermaglie sono già iniziate: il Commissario europeo al clima Frans Timmermans ha detto stamattina che l'Unione europea non esclude una carbon tax sulle importazioni per proteggere la propria economia dalla competizione di chi produce inquinando impunemente: forse una replica alla Cina, fra i principali esportatori verso il vecchio continente. Gli ha risposto l'India, segnalando a mezzo stampa che gli obiettivi europei sulle emissioni non considerano tutta la filiera (le cause), ma solo i consumi (l'effetto). Eppure un terzo del carbonio emesso dall'UE - ma non conteggiato nelle ipotesi di riduzione - sta proprio in queste catene, che gli stati membri hanno allungato delocalizzando la produzione proprio nei paesi asiatici.
9 dicembre
Sul palco di una enorme sala quadrata al fondo del complesso Feria de Madrid, si è tenuta stamattina una consultazione fra delegati dei governi sul tema più scottante di questa COP25: l'Articolo 6 dell'Accordo di Parigi, in base al quale dovrebbe nascere un nuovo sistema di scambio delle emissioni di carbonio. Grazie a questo meccanismo, parte delle riduzioni delle emissioni che gli stati si sono impegnati a raggiungere verrà affidata a un mercato finanziario. Funzionerà così: un paese potrà ridurre le emissioni investendo in progetti, tecnologie e impianti a basso impatto sul territorio di un altro paese. Questo progetto di mitigazione potrà entrare poi a far parte dell'impegno di riduzione delle emissioni che il paese investitore ha presentato alle Nazioni Unite. La ratio è che investire nei paesi in via di sviluppo potrebbe costare meno per i paesi ricchi, nel contempo garantendo una riduzione globale delle emissioni. Tuttavia, questo ragionamento ha numerosi punti oscuri. Come funzionerà il commercio dei crediti di carbonio esattamente? La bozza in discussione oggi - in serata ne uscirà una più aggiornata - è piena di trappole per annacquare i conteggi e rendere questo sistema virtualmente inutile a garantire per una vigorosa riduzione delle emissioni. Alcuni paesi, fra cui l'Australia e il Brasile cercano di minare il documento finale per poter ridurre al minimo, o addirittura annullare i loro sforzi. L'Unione europea rimane tiepida, alimentando i rischi di chiudere un documento che replica gli errori del passato.
Non c'è nulla di nuovo nel modo in cui le parti si confrontano oggi rispetto a quel che fecero quando si trattò di costruire il sistema di scambio delle emissioni in seno al Protocollo di Kyoto. Grazie a regole deboli e obblighi inesistenti, il mercato del carbonio già allora legittimò investimenti di dubbia sostenibilità (ad esempio le grandi dighe) e in contrasto con il rispetto dei diritti umani. Non di rado alle comunità locali è stato ridotto l'accesso alle risorse, perché foreste, fiumi o altre "nature" nelle quali vivevano da sempre dovevano essere "utilizzate" da imprese di altri paesi come "banche di carbonio". Per fare un esempio, i paesi ricchi o le loro imprese hanno potuto comprare terreni o foreste nei paesi più poveri, togliendoli alle comunità indigene, in modo da utilizzarli per assorbire CO2 e compensare la mancata chiusura o modernizzazione di stabilimenti inquinanti nei paesi ricchi, dove queste industrie contribuiscono alla crescita economica e all'occupazione. Questo gioco delle tre carte prosegue ora come allora, e nonostante gli avvertimenti e le proteste degli attivisti non sembra che possa davvero cambiare qualcosa. Alcuni paesi continuano a chiedere che ogni riferimento ai diritti umani o delle comunità native resti fuori dal documento finale sull'Articolo 6, per non "politicizzare" l'argomento. Ma considerare la terra, gli alberi o l'acqua come risorse finanziarie da barattare su un mercato dedicato tradisce un vizio di base nell'approccio complessivo al tema del cambiamento climatico e alla questione ancor più generale del rapporto che il sistema di governance internazionale ha costruito con la rete della vita sul pianeta. Se non muta questa visione di fondo, è difficile che qualcosa possa radicalmente cambiare.
7 dicembre 2019
Erano mezzo milione ieri nelle strade di Madrid, per manifestare contro l'immobilismo dei governi di fronte alla crisi climatica. Giovani, tanti, ma altrettanti meno giovani, provenienti da ogni parte del mondo hanno marciato per quattro chilometri fra Atocha e Nuevos Ministerios chiudendo nella città dove ha luogo la COP 25 un'annata di grandi mobilitazioni per l'ambiente. Il corteo ha ospitato al suo cuore una nutrita rappresentanza del popolo mapuche, determinata e rumorosa contro le violenze del governo che in queste settimane presiede la Conferenza ONU sul clima, pur avendo rinunciato ad ospitarla dopo la crisi politica innescata dalla rivolta della sua gente. Sul palco della manifestazione Greta Thunberg ha ricordato ancora una volta che non abbiamo più tempo per rispondere alle sfide che il clima ci pone davanti, ma ha lasciato i dimostranti con un messaggio positivo: "il cambiamento è già in atto", che piaccia o meno a chi detiene oggi le leve del comando.
La mobilitazione oggi si è travasata negli oltre 350 fra incontri, conferenze, laboratori e dibattiti che animano la Cumbre Social, il controvertice messo a punto dentro l'Università Complutense dai movimenti sociali, dagli studenti e dalle organizzazioni ambientaliste fino al 13 dicembre. Ci siamo emozionati durante l'inaugurazione, quando i rappresentanti dei popoli indigeni dell'America del Nord, insieme a quelli dell'Amazzonia Brasiliana e ancora una volta al popolo Mapuche, hanno intonato canti rivolti al cosmo e alla madre terra. Queste donne e uomini venuti da un altro tempo non ci colpiscono soltanto per le piume o gli scialle multicolori, ma per la chiarezza del linguaggio e la semplicità con cui pongono i problemi e suggeriscono soluzioni. La loro lotta per conservare spazi di esistenza e comunità nei territori più incontaminati del pianeta ha fatto breccia anche nelle stanze del vertice ufficiale. Tutti qui, dai governi alle ONG, fino ai rappresentanti del settore privato, cominciano a parlare dell'antico sapere indigeno come una fra le strade possibili per combattere la crisi climatica attraverso le cosiddette "nature based solutions" (soluzioni basate sulla natura), una pletora di misure che comprendono l'uso più sostenibile del suolo, dell'acqua, il ripristino degli ecosistemi a rischio. Ma l'improvvisa passione da parte dell'élite globale per le conoscenze ancestrali dei nativi non convince i rappresentanti di queste popolazioni. Oggi all'incontro fra i governi e la società civile Jamene Yazzie, dell'International Indian Treaty Council, lo ha detto chiaramente: "Sono sempre di più i non indigeni che parlano di noi e per nostro conto. Noi siamo qui, per i nostri figli e per i nostri avi, sappiamo di avere risposte a questa crisi: se le accettate anche voi significa che state ammettendo che il modello di sviluppo estrattivo promosso fino ad oggi è sbagliato. Se invece cercate di utilizzare i nostri saperi per inserirli in soluzioni basate sul mercato, per noi è inaccettabile".
Fra schermaglie e lunghi negoziati, discussioni interminabili ed eventi che servono spesso a farsi soltanto un po' di pubblicità, prosegue intanto la trattativa sotterranea per giungere a definire un sistema di contabilizzazione comune, in modo da poter fare il monitoraggio globale dei progressi dei vari impegni presi dai singoli paesi.
A far saltare il banco potrebbe essere però il cosiddetto Articolo 6 dell'Accordo di Parigi, che apre alla possibilità di creare un mercato globale del carbonio sul quale scambiare quote di emissioni. Questo sistema è stato chiesto fortemente dal Brasile e può essere molto rischioso per le scappatoie che potrebbero esservi inserite. Dovrebbe servire a decarbonizzare l’economia a costi inferiori, finanziarizzando parte degli impegni. In particolare un paese potrà ridurre le emissioni investendo in progetti, tecnologie e impianti a basso impatto in un altro paese, che potendo poi conteggiarle però nel proprio impegno presentato all'ONU. Tuttavia, già in passato questi meccanismi si sono rivelati inefficaci e spesso dannosi. Per questo i negoziati su questo capitolo sono in stallo da cinque anni, e ora i nodi sono al pettine. Entro i prossimi giorni tutti gli osservatori si aspettano un accordo, ma si teme che sarà l'ennesimo compromesso al ribasso.