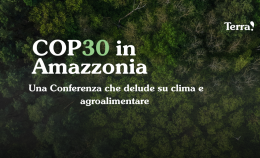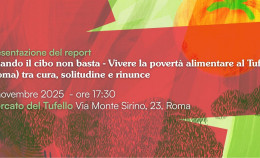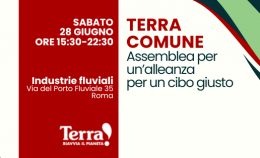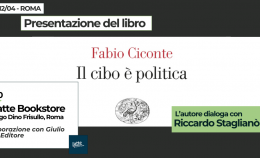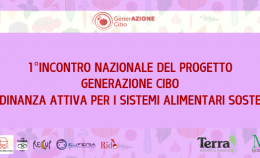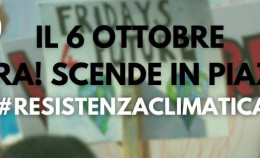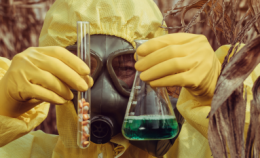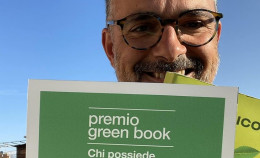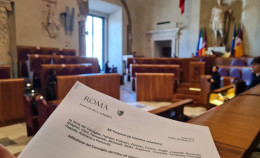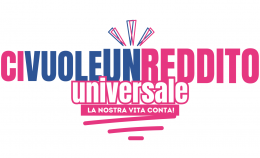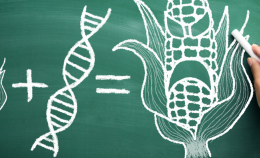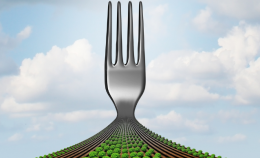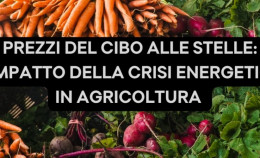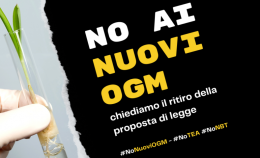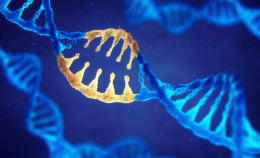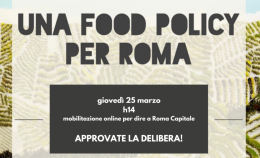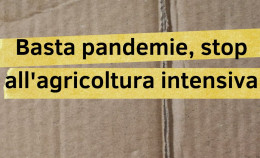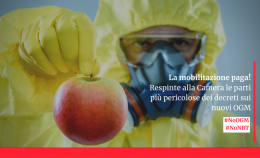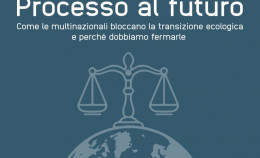COP30: una Conferenza che delude su clima e agroalimentare
Pubblicato da Federica Ferrario
il 24/11/2025
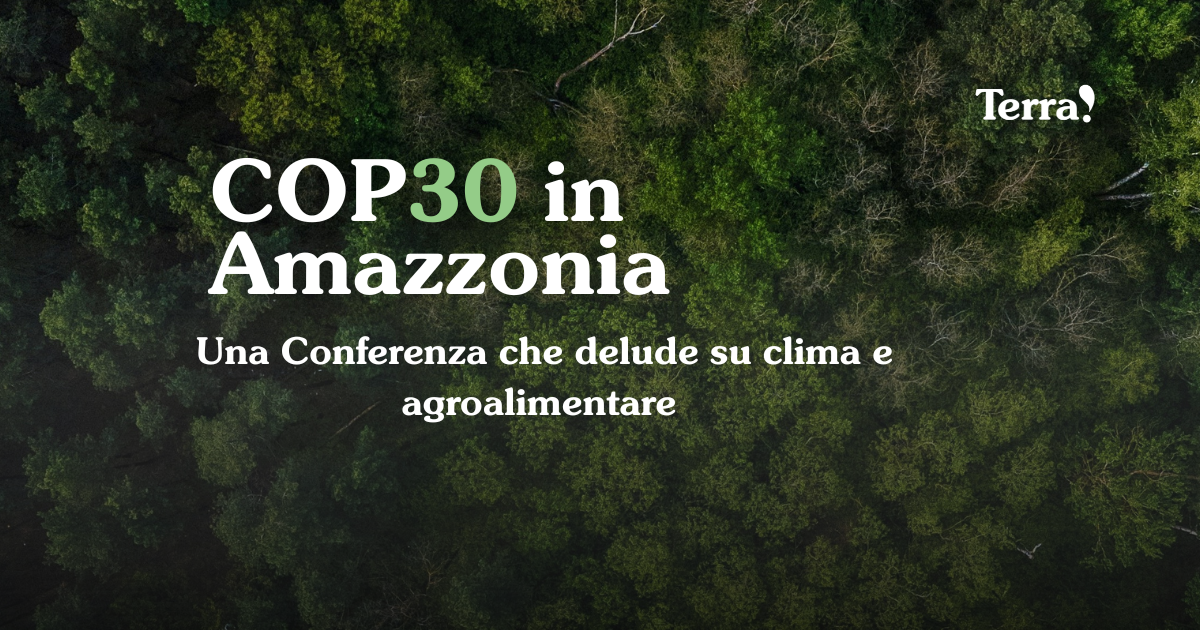
Alla fine della COP30 di Belém, l’insoddisfazione è la sensazione che rimane con maggiore forza. Pur essendo stata presentata come la “COP della verità”, il summit ha mancato clamorosamente gli obiettivi essenziali sia nella lotta alle fonti fossili sia nella trasformazione dei sistemi agroalimentari, oggi responsabili di una quota crescente delle emissioni globali e della crisi climatica.
Nessuna roadmap sulle fossili
La questione più divisiva e discussa era la creazione di una tabella di marcia globale chiara e condivisa per il superamento dei combustibili fossili, richiesta da ben 86 Paesi e da ampie porzioni della società civile. Malgrado le proteste e le pressioni di attivisti, comunità indigene e delegazioni di Stati più lungimiranti, il documento finale non cita nemmeno esplicitamente le fonti fossili. Potremmo quasi definirla una paradossale retromarcia rispetto ai timidi “progressi” delle COP precedenti. Paesi come Arabia Saudita, Russia e altri forti produttori di fossili hanno imposto il veto, mentre all’interno dell’Unione europea abbiamo assistito a imbarazzanti divisioni tra paesi che spingono per la necessaria transizione e altri, come l’Italia, che si sono mostrati riluttanti. Gli strumenti proposti – il Global Implementation Accelerator e la Belém Mission to 1.5 – appaiono procedure volontarie e poco vincolanti, di fatto rinviando ancora una volta l’attuazione concreta della transizione energetica.
I sistemi agroalimentari ancora ignorati
Sul fronte dell’agroalimentare, COP30 si chiude senza alcun reale riconoscimento al ruolo dei sistemi agroindustriali nella crisi climatica globale. L’agricoltura intensiva, che dipende fortemente dai combustibili fossili e da materie prime trasformate in “commodities” (merci), non è stata affrontata nei negoziati, nonostante sia responsabile di circa un terzo delle emissioni mondiali e della gran parte della deforestazione tropicale. Il cibo sembra apparire nel testo finale solo come indicatore marginale di “produzione alimentare resiliente al clima”. Sono stati indeboliti anche gli impegni sulla deforestazione e sulle cause strutturali dello sfruttamento delle risorse naturali mondiali. A pesare sono state le pressioni dei grandi lobby agroindustriali.
Finanza climatica e adattamento: risultato parziale
L’unico elemento di parziale avanzamento riguarda la finanza climatica: è stato approvato un aumento dei fondi per l’adattamento nei Paesi vulnerabili. Entro il 2035, i finanziamenti saranno triplicati fino a 300 miliardi di dollari, e sono stati avviati nuovi processi e fondi dedicati. Tuttavia, la mancanza di una visione integrata sulla mitigazione e su come affrontare i veri nodi della crisi climatica lascia l’intero processo in una profonda ambiguità.
Bene la “Dichiarazione di Belém su Fame, Povertà e Azione Climatica” incentrata sui piccoli produttori e di come sono maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici e custodi fondamentali degli ecosistemi – anche se il testo non sembra voler distingue fino in fondo tra l’agricoltura industriale dipendente dai combustibili fossili e l’agroecologia, necessaria per nutrire il mondo in un contesto di crisi climatica sempre più rapida.
Bene anche i 24 paesi che hanno firmato l’iniziativa di Colombia e Paesi Bassi per organizzare una conferenza internazionale sulla transizione dai combustibili fossili in Colombia, ad aprile 2026 (e anche qui, Italia non pervenuta…).
Un futuro più incerto
La COP30 conferma la radicalizzazione geopolitica e la difficoltà del “sistema multilaterale” di rispondere alle vere urgenze climatiche: la mancanza di leadership, il prevalere degli interessi dei grandi produttori fossili e agroindustriali e le ambiguità dei paesi chiave, Europa in primis, stanno mettendo sempre più in discussione quanto raggiunto con l’Accordo di Parigi.
A mancare è soprattutto la volontà di affrontare insieme, con coraggio e chiarezza, le sfide della transizione dai fossili e della riforma dei sistemi agroalimentari. Finché questi nodi non saranno sciolti, emissioni, deforestazione, crisi del cibo e disuguaglianze andranno solo ad aggravarsi, lasciando il pianeta e le generazioni future ancora più vulnerabili.
Ne parliamo il prossimo 2 dicembre alle 18 su Zoom con Ferdinando Cotugno e Federica Ferrario.
Iscriviti qui